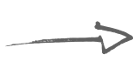Germania, 1958. Michael Berg, studente quindicenne, preso da un malore per la strada, viene aiutato e riaccompagnato a casa da Hanna Schmitz, donna sulla trentina che lavora come controllore sulle linee tramviarie. Guarito dalla malattia Michael torna a casa di Hanna per ringraziarla della sua premura ed i due intrecciano una relazione, che si conclude con il finire dell'estate. Hanna inizia Michael alla sessualità e lui legge ad alta voce per lei i classici della letteratura.
Qualche anno dopo Michael, ora studente di giurisprudenza, incontra di nuovo, del tutto inaspettatamente, Hanna: è imputata in un processo a carico di un gruppo di ex SS, accusate di aver lasciato morire, bruciate vive, trecento donne ebree. Hanna verrà riconosciuta colpevole della colpa più grave e quindi le viene comminata una pena più dura rispetto alle altre imputate: il carcere a vita. Hanna avrebbe potuto scagionarsi dalle accuse dichiarando di non saper nè leggere nè scrivere e quindi di non essere stata lei a redigere il verbale, firmato da tutte le imputate, in cui fu riportato dettagliatamente, come era proprio dei nazisti, tutto quello che era avvenuto quella tragica notte (cosa che però difficilmente la renderebbe meno colpevole dal punto di vista morale). Ma Hanna tace e confessa il crimine, temendo di più di dover affrontare la vergogna di essere analfabeta, vergogna che si è portata dietro per tutta la vita, piuttosto che il carcere.
The Reader (il cui titolo in inglese conserva l'intrigante attribuzione sia maschile che femminile) è un film che sintetizza il cinema precedente di Stephen Daldry: da una parte affronta il tema dell'adolescenza, della cresita come in Billy Elliot, e dall'altra parte è una storia che si muove su più scenari narrativi, con salti dal passato al presente e l'intrecciarsi si tematiche differenti, come in The Hours.
Nella prima parte il film affronta con sguardo indagatore il tema della sessualità dal punto di vista del protagonista maschile che si mescola con la sete di cultura letteraria di Hanna. Ma questo primo intreccio di tematiche viene abbandonato, quasi bruscamente, per concentrarsi su un'altra serie di tematiche, direi ancora più complesse delle precedenti. In questa seconda parte il tema centrale è il senso di colpa, che viene analizzato (senza comunque poter arrivare ad una conclusione oggettiva, com'è naturale che sia) attraverso l'incontro/scontro tra due generazioni. Hanna appartiene a quella generazione che è cresciuta e vissuta per gran parte della sua vita nella Germania nazista, la cui mentalità risulta oggi quasi incomprensibile, mentre Michael rappresenta la generazione successiva, una generazione che sente forte su di se il senso di colpa per quello che hanno fatto (o non hanno fatto) i loro connazionali negli anni '30 e '40. Da una parte quindi condannano e non possono perdonare per ciò che è stato fatto, ma dall'altra si domandano come sia possibile odiare per questo le persone che comunque si amano incondizionatamente, come, per esempio, i genitori: non si sceglie mai chi si ama. E quella di Michael è una generazione che cerca di scrollarsi di dosso il passato ed il senso di colpa per poter andare avanti.
In The Reader non vengono fatte condanne nè viene data alcuna assoluzione. E' difficile condannare Hanna, ma è altrettanto difficile perdonarla per quello che ha fatto.
E ci si rende anche conto di come spesso la condanna morale non coincida con quella legale, giuridica e di come sia difficile attribuire colpe.
Il film può vantare un cast d'eccezione con attori del calibro di Kate Winslet (che, sempre più brava ed intensa, si è aggiudicata l'Oscar per questa pellicola), Ralph Fiennes e Bruno Ganz. Il cast è composto interamente da attori ed attrici tedeschi (fatta eccezione per la Winslet e Fiennes) sui quali spicca il promettente David Kross nei panni del protagonista maschile.
« ...che cosa ho imparato? Ho imparato a leggere. »